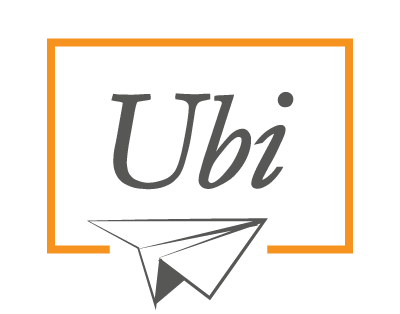Un dialogo sulla città, vista da dentro, tra luci e ombre
L’ultimo è stato Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, tuttavia la lista di intellettuali, scrittori e critici, ma anche persone comuni, che in questi giorni hanno in qualche modo esternato un commento sulla scia di «Meno male che c’è Fran Lebowitz», potrebbe essere molto più lunga. Poche, a onor del vero, le critiche, forse perché l’esigua minoranza che non ha molto amato la docu-serie di Martin Scorsese Pretend it’s a city (letteralmente, “Fate finta che sia una città”, anche se il titolo ufficiale in italiano è Fran Lebowitz. Una vita a New York) in streaming ora su Netflix, ha preferito non esternare il proprio disappunto. Sette puntate da mezz’ora l’una. Protagonista la scrittrice che non scrive un libro da trent’anni. È lei l’intellettuale caustica, l’assidua frequentatrice di feste («ecco perché Marty [Scorsese] ha girato così tanti film, e Fran ha scritto così pochi libri» sottolinea divertita ad un certo punto), l’icona newyorkese che ha fatto del public speaking il suo modo di sbarcare il lunario, e che snocciola una ad una le sue opinioni su (quasi) tutti gli argomenti, anche se il tema preferito e centrale di tutta la serie rimane la città di New York. Sarà per il fatto che, alla fine l’auto-ironia della Lebowitz strappa sorrisi, sarà che non siamo più abituati a qualcuno che metta da parte, ma sempre con onestà ed intelligenza, certi discorsi tipici del politicamente corretto, il docu-film risulta interessante. Tuttavia, non si può non che concordare con Brian Lowry, che su CNN ha scritto che 3 ore e mezza dedicate alla saggezza e alla prontezza di spirito della Lebowitz, «sono un po’ troppe».

©Paola Giorgi
Fran Lebowitz è soprattutto una vera newyorkese, anche se non di nascita, lo è sicuramente per spirito e humour, e per questo motivo nella serie è difficile scindere la protagonista dal luogo in cui vive e, soprattutto, cammina. Una città che si riflette nel suo carattere arguto e senza peli sulla lingua, ma che dall’altra rispecchia un certo provincialismo tipico dell’eco-sistema della metropoli americana, una certa aura di unicità che rende la Grande Mela e i suoi abitanti così speciali (ai loro occhi), sia dentro gli Stati Uniti che fuori, nel resto del mondo. Forse è anche per questo un motivo che la serie a tratti risulta prolissa e auto-referenziale, se non fosse per il piglio della protagonista.
L’amore della Lebowitz per la metropoli è schietto e diretto – «nessuno può permettersi di vivere a New York! Ma siamo comunque 8 milioni di persone!» esclama ad un certo punto ad un visibilmente divertito Scorsese (le sue rumorose risate sono oramai un must di qualsiasi articolo che parli di Pretend it’s a city). E ancora, «New York non è mai noiosa», per continuare con un «Quando le persone ti chiedono, “Perché vivi a New York? Non sai cosa rispondere. L’unica cosa che sai è che disprezzi quelli che non hanno le palle di viverci”».
La Lebowitz cammina incessantemente. «Sono l’unica persona che guarda dove va in mezzo a milioni di persone», rimarca, tra una scena in cui inveisce contro una Time Square dove l’allora sindaco Michael Bloomberg aveva fatto installare delle sdraio – «Quanto sono costate? Quaranta milioni di dollari, soldi dei contribuenti. Non è stato neppure un suo regalo, 40 milioni di soldi dei contribuenti, ok? Solo perché sicuramente c’erano stati tantissimi newyorkesi che avevano detto: “Sai cosa odio di New York? Che non ci sia abbastanza posto dove sdraiarmi a Time Square”!» – o le piastrelle dorate della Library Walk che portano alla New York Public Library.
Ma la Lebowitz non è parca nemmeno di critiche alla metropoli americana, soprattutto al suo sistema dei trasporti, come quando, facendo riferimento alla chiusura per 5 mesi della stazione vicina a casa sua per l’allestimento di un’installazione artistica, dice: «l’hanno chiamato “potenziamento della stazione”, non “ripareremo la metropolitana”, metropolitana che è andata, binari, cartelli e vagoni rotti, ogni singola cosa è andata. Non potenziano la stazione ma si preoccupano di un’installazione artistica!», per chiosare con un:
«Basterebbe anche solo una corsa sulla metropolitana di New York a trasformare il Dalai Lama in una persona lunatica e irascibile!»
FRAN LEBOWITZ

©Paola Giorgi
Nonostante il format preveda di privilegiare set semplici, New York viene omaggiata anche nella scelta degli interni e degli esterni, mostrando da parte del regista e del cast una profonda conoscenza dei luoghi iconici della metropoli americana, a partire dagli interni. Dallo storico club The Players , fino alla stessa biblioteca comunale, passando per Grand Central Station, ma soprattutto il Queens Museum, con il suo Panorama della città di New York: un enorme plastico in miniatura che rappresenta la città, progettato da Robert Moses – uno degli artefici di quella ristrutturazione modernista dellaGrande Mela tanto criticata da Jane Jacobs – per l’Esposizione universale del 1964, e attorno il quale Lebowitz si muove in stile Godzilla. Un plastico dove le luci si accendono e si spengono – «puoi capire come cambia la città a seconda di come cambiano le luci» dice ancora la scrittrice – e dove ogni edificio, ogni monumento, ogni strada sono minuziosamente ricostruiti.
Protagonista è anche l’architettura: l’Empire State Building e la Lever House, simbolo dell’espansione di New York e del suo straordinario sviluppo, fanno da contraltare ai nuovi, altissimi, grattacieli sulla 57esima strada, quasi irreali e «copiati»dagli Stati del Golfo. «Il mondo è rimasto sbalordito dai nostri grattacieli – racconta la Lebowitz –, qualcuno ce li ha anche invidiati. Per esempio, negli Stati del Golfo, hanno costruito questi orribili, altissimi edifici, in mezzo al deserto. E poi noi li abbiamo copiati! – continua –. New York in generale non è mai stata una città particolarmente bella. Almeno prima era originale, adesso la 57esima strada sembra uno di quegli Stati del Golfo, se non fosse che almeno è un posto reale».
Che cosa si salva quindi? Sicuramente la maestosa Gran Central Station, «il motivo per cui è così bella è perché una sola persona l’ha progettata. Oggi un edificio di queste dimensioni non verrebbe mai costruito da una persona sola, con una sola sensibilità».

©Paola Giorgi
Ottimo il montaggio di David Tedeschi e Damian Rodriguez laddove, alle immagini girate nei mesi pre-Covid contraddistinti da grandi affollamenti e orde di turisti, affianca fotogrammi d’epoca, dei primi anni ’30, di una New York quasi irriconoscibile, a tratteggiare una linea indelebile che lega quella città a quella di oggi. Ed è forse la New York degli anni ’70, quella dell’epoca più violenta, più dura, quella sull’orlo della bancarotta, della quale Lebowitz sembra avere più nostalgia. Un luogo urbano, quasi mitico, dove gli appartamenti non costavano ancora 20 milioni di dollari e le strade non erano prese d’assalto da visitatori stranieri, ai quali la Lebowitz chiede, almeno, di «Pretend it’a city!».
Immagine di copertina ©Paola Giorgi
©RIPRODUZIONE RISERVATA